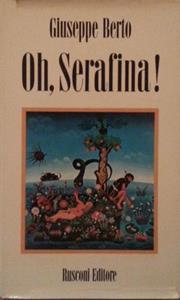 Giuseppe Berto, “Oh Serafina! Fiaba di ecologia, di manicomio e d’amore”, Rusconi editore 1973
Giuseppe Berto, “Oh Serafina! Fiaba di ecologia, di manicomio e d’amore”, Rusconi editore 1973
Le bancarelle: una volta al mese, a Treviso, sotto la Loggia dei Cavalieri, si tiene la “Mostra mercato del libro antico, raro, introvabile”. Cerco di non frequentarla con regolarità, a tutela delle finanze familiari e degli scaffali di casa. Capita, tuttavia, anche senza alcuna intenzione, di passare di lì, proprio nel giorno giusto.
Sono sempre le piccole cose a rallegrare la giornata: una copia, rivelatasi una prima edizione, Rusconi Editore 1973, di “Oh Serafina!” di Giuseppe Berto. Un libro che mi mancava, di un autore che amo.
Due chiacchiere con il venditore, un saluto, e mi raggiunge il ricordo della locandina del film, tratto dal libro, che al tempo, era il 1976, non ho veduto. La memoria ne ha conservato l’immagine: un giovane Renato Pozzetto, piccoletto, cicciottello, sguardo vuoto-fisso-libidinoso, calamitato-appiccicato alla alta statuaria procace Angelica Ippolito.
Soggetto, e collaborazione alla sceneggiatura, di Giuseppe Berto. Con Renato Pozzetto, Dalila Di Lazzaro, Angelica Ippolito. Regia di Alberto Lattuada.
Ci scommetterei qualcosa che, in quegli anni la sottoscritta – più o meno battagliera giovane mamma ancora sulle barricate (in Italia era stato da due soli anni confermato con referendum il divorzio e la battaglia in corso riguardava quella che sarebbe poi stata la legge 194/79, con temi annessi e connessi) – deve essersi persa il film causa un solido pregiudizio ideologico militante. Come dev’essere avvenuto per il libro, peraltro: al tempo non letto.
È un libro (ingiustamente) non considerato, forse, tra i capolavori di Giuseppe Berto che, di suo, ha scritto la quarta di copertina, presentandolo così:
“Ho scritto questo libro perché avevo bisogno di soldi. Mi capita spesso di aver bisogno di soldi: non guadagno poi molto, sono imprevidente nelle spese, e lo Stato mi fa pagare troppe tasse. Di solito, risolvo questi problemi di denaro lavorando per il cinema. (…)”
E tuttavia, gli è scappato di mano un gran bel libro; che, nelle intenzioni dell’autore, e nella prima stesura, doveva essere una sceneggiatura. Senonché – ci dice ancora l’autore:
“(…) i più importanti produttori italiani non lo comprarono, perché non ci vedevano nulla… Allora mi venne in mente di farne un libro, perché io ci vedevo qualcosa. Non sono affatto pentito di averlo scritto tant’è vero che lo pubblico. Non è sicuramente un libro a me estraneo. Vi ho messo il mio humour, che ho imparato con lunghe e dure sofferenze, vi ho messo la mia pietas (…) Dei motivi che si trovano costanti nelle mie opere, qui manca solo, io credo, il senso della morte, ma questa è una favola e i personaggi delle favole non hanno paura di morire perché, si sa, vivranno per sempre felici e contenti.”
Il lettore troverà davvero più di qualcosa, in questo libro, che è una piccola opera d’arte. Sottotitolo: “Fiaba di ecologia, di manicomio e d’amore” – e non si poteva farne una sintesi migliore.
Un libro sorridente, favoleggiante, e pensoso, a suo modo; in cui la voce dell’autore, la sua ironia, si fa leggera e, come da lui stesso detto, carica di una pietas che ingloba tutti i personaggi, anche i “cattivi”, che svolgono al meglio il proprio ruolo: sono senza colpa; sono così, inutile prendersela, già di loro non potranno avere una vita buona che neppure sanno possa esistere.
Il film ne è seguito. Ne ho trovato il video, internet offre questa possibilità – e per chi lo desiderasse, qui: (avverto che non l’ho ancora visto, solo uno  sguardo per confermarmi che di esso si tratta).
sguardo per confermarmi che di esso si tratta).
Tra libro e film, pure se non ancora veduto, una cosa si può dire, dal punto di vista del lettore: il protagonista, Augusto Secondo, piccolo imprenditore, titolare di una fabbrica di bottoni alla periferia di Milano, non può avere che la faccia e la presenza di Renato Pozzetto. La sceneggiatura all’origine del libro dev’essere stata pensata per lui.
Un accenno alla vicenda, che comincia con un riassunto della storia familiare e della storia della “fabbrichetta” (secondo me da leggere/pensare, assolutamente, con la <è> milanese aperta).
C’era stato un nonno, Augusto Valle, proprietario della FIBA, fabbrica di bottoni dalle parti di Sesto, vicino a Milano, “un lungo stanzone che era stato una stalla, con circa trenta tra operai e operaie e in più alcune macchine tedesche che, a prezzo di non poco rumore, fabbricavano bottoni d’osso e di madreperla.”
La proprietà, dove anche la famiglia Valle viveva, comprendeva un parco di mezzo ettaro, alle spalle della casa, fitto d’alberi.
Augusto Valle era stato un grande appassionato di aeroplani, tanto che l’acronimo FIBA valeva come Fabbrica Italiana Bottoni e Aeroplani. Nelle intenzioni di Augusto Valle, i bottoni sarebbero stati unicamente un punto di partenza, per farci un po’ di soldi, e poter poi trasformare la produzione in aeroplani.
“Tra Augusto Valle e gli apparecchi volanti esisteva, si può dire, una sorta d’arcano legame, o connessione metafisica, e in verità il brav’uomo era sopravvissuto a un incredibile numero d’atterraggi di fortuna sui campi di barbabietole finché, nel luglio del ’44, morì in Piazza Cordusio, a Milano, sotto un bombardamento, naturalmente aereo.” Nel testamento aveva lasciato la proprietà non al figlio Giuseppe, sposato con tale Belinda Sassi, donna dal pessimo carattere che aveva rovinato la vita al marito, bensì al nipote, che portava il suo nome e gli somigliava come una goccia d’acqua (baffoni a parte), e che pertanto veniva chiamato Augusto Secondo.
Ambiente familiare difficile per il piccolo Augusto Secondo, tra il padre, mite e buono che si rifugiava in fabbrica per sfuggire una moglie pestilenziale, e la madre che, in aggiunta, non sopportava neppure il bambino prima, il figlio adulto poi, che trascorreva le sue giornate da solo, nel parco, a prendersi cura degli uccellini.
Gli uccelli avevano imparato a conoscere Augusto Secondo, a mangiare dalle sue mani, a posarsi fiduciosi su di lui. Ed egli li conosceva ad uno ad uno, e ad ognuno aveva dato un nome. Augusto Secondo “parlava” con gli uccelli.
“Così passavano gli anni. La FIBA restava com’era, modesta fabbrichetta sempre più vecchiotta con alle spalle il suo mezzo ettaro di parco dove gli alberi, piantati da chissà quale bisavolo, crescevano. Intorno, invece di alberi, crescevano fabbriche e case, fabbriche e case, sempre più fabbriche e case, finché non ci fu più cielo né ci furono più stagioni, e gli uomini lavoravano molto dicendo ma che caldo boia ma che freddo boia, e la domenica si facevano due o anche tre ore di macchina per andare a vedere, quasi sempre in Svizzera, com’era fatta l’aria pulita. Insomma, intorno alla FIBA e senza che la FIBA facesse niente per meritarselo, era scoppiato il miracolo economico.”
Dimenticati gli aeroplani, rimasti solo nella ragione sociale della ditta, il volo, in qualche modo, rimaneva il sogno, diversamente declinato, del nuovo titolare della FIBA.
Augusto Secondo dedicava poco tempo alla produzione dei bottoni. A parer suo era sufficiente che le maestranze continuassero a gestire la produzione secondo le direttive dell’amato nonno. E trascorreva tutto il proprio tempo nel parco.
Unico suo altro interesse, tardivamente scoperto, era stato il sesso, che lo fece finire sposato a una bellona, tale Palmira Radice, operaia alla FIBA, donna un po’, e anche un po’ di più, promiscua, che non tollerò a lungo un marito costantemente arrapato per un verso e per l’altro totalmente disinteressato a lei in favore degli amatissimi passeri.

Ed ecco snodarsi la fiaba, che già era intuibile nel pregresso della storia di famiglia, in quella vena di fantasia e originalità nascosta sotto l’apparenza di industrialotti piccolo-borghesi-benestanti-conservatori, tormentati dalle mogli, degli uomini Valle, capaci, a dispetto delle apparenze, di coltivare un sogno.
Nella vita di Augusto Secondo interverrà, come in ogni buona fiaba che si rispetti, un qualcosa che romperà l’equilibrio di vita del protagonista, dando il via alle peripezie dell’eroe; con l’intervento di una improbabile “fata” – in veste manicomiale, lo sappiamo dal sottotitolo – figura femminile in totale discontinuità con la storia di famiglia.
Ancora il sottotitolo ci dice infatti che si tratta di una fiaba d’amore.
Quanto alle streghe, beh, le parti sono sostenute benissimo dalle mogli – con quel filo di misoginia d’epoca (e anche no) sintetizzato da Augusto Secondo con un chiaro “Donna, rompi no le bale”, detto alla madre, e finita lì.
Ho fatto bene, dopotutto, a non leggere questo libro, e a non vedere il film, in gioventù. Avrei potuto avere reazioni inconsulte.
Una fiaba ecologica: a quarant’anni di distanza, la storia cattura – fin dalla descrizione di quelle ore in auto a cercare, fino in Svizzera, un po’ d’aria buona, fuggendo dall’agognato miracolo economico e da un mondo, tra Milano e la Brianza, di fabbriche e case e case e fabbriche, in tutta la sua desolazione.
Dopotutto, inavvertitamente, anche in questo libro un po’ del suo abituale senso della morte, l’autore ce lo ha infilato.
È un libro che si legge di getto, così come dev’essere stato scritto. Nascono così le piccole opere d’arte; con i piccoli colpi di genio del momento buono.
