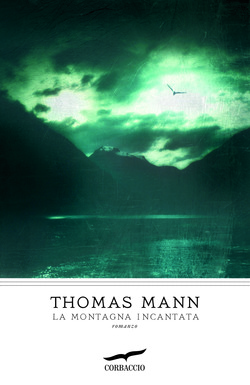Thomas Mann, “La montagna incantata”, Corbaccio 2011
Thomas Mann, “La montagna incantata”, Corbaccio 2011
Avevo anticipato questa rilettura in corso più di un mese fa. (qui: per una breve sinossi).
Ora, lungi da me l’idea, non osabile, di una recensione di questo capolavoro, e invece il desiderio di raccontare sprazzi di un’esperienza di lettura; unica, frutto, certo, di un “incantesimo” che l’autore ha operato: su di me. Su di sé? Per fuggire il mondo che, dopo la tragedia della Grande Guerra, vedeva evolvere in pazzia una pace mai stata.
Iniziato nella forma di un racconto, nel 1912, il libro è stato pubblicato nel 1924 – la nuova tragedia di là da venire ma già in gestazione; ancora sconosciuta, i cui tratti si facevano via via più chiari mentre la speranza dei primi anni di Weimar illudeva. A latere, il genio di Thomas Mann, la vista periferica che, ancora negando, <vedeva>?
Dentro queste pagine mi ha catturato, oggi e qui, un incantesimo che narra, a chi vuol sentire, di coscienze ammalate, di una sospensione del tempo, di un respingimento della morte, la propria, nell’altro e dell’altro, negata da un dispositivo finalizzato a congegnare un fermo-tempo, all’interno di una accogliente gabbia; aperta, spalancata sul confine infinito e chiuso di un paesaggio di alta montagna, lo sguardo alle nevi eterne; caldamente claustrofobico, dentro il piccolo mondo chiuso del Berghof di Davos, segnato da riti e miti condivisi nelle ore da trascorrere su di una comodissima chaise longue, avviluppati dentro un utero-coperta, caldo e rassicurante nel gelo esterno; segnato da una compagnia rituale nel corso di pranzi e cene, tavoli-isole di gruppi – nazionalità – appartenenze sociali.
Per chi lo poteva, per ricchi borghesi, ognuno con la propria storia e le proprie possibilità di costruirla, come ottusi criceti disperati isterici che girano, girano.
Sono colta, leggendo, da strane associazioni, immagini di antichi film, legami impropri con le pagine in lettura.
“Il giorno della marmotta”, poi (e ancora, che c’entra?) “L’anno scorso a Marienbad”. Strane associazioni compongono, sempre, la vita, costruita, per ognuno di noi, di ricordi assemblati da una ragione ignota; come il romanzo che ogni giorno scegliamo di leggere nel nostro incontro-scontro con i giorni e – ma c’è? – la realtà.
La pianura – il piano, della realtà – è laggiù, illusoriamente negato. Là dove tutto, con fatica, accade.
Leggo oggi, rileggo; sono, è ovvio, un’altra persona; e vivo, oggi, in un mondo che – non si può dire.
La gestazione dell’opera ha percorso il tempo in cui tutto si compiva; e in cui tutto si preparava, ancora, ad accadere; lo stesso, diverso film, fino al momento del bisogno di dare forma ad una Profezia Indicibile, e nel contempo ripararsene – la malattia, socialmente impronunciabile; il germe – morale – di cui rimuovere la realtà.
La storia finisce – la realtà riprende i suoi diritti – allo scoppio della guerra.
Meglio sostare, ancora una volta, agli anni in cui tutto stava – sta? – maturando.
Chiudere gli occhi per non vedere significa aver veduto. Significa la fatica di rimuovere. Dove non un gesto, un pensiero, infragilisca l’incantesimo.
Thomas Mann vede? E ci restituisce la negazione, con la forza, tutta interna, nascosta, del disvelamento?
“Dove siamo? Che è questo? Dove ci ha sbalestrati il sogno?”
Sto esitando, rallentando, nel chiudere le ultime pagine di questo libro. Non lo vorrei chiudere. Non perché catturata dal fascino della storia, dall’aver stabilito, io lettrice, un legame con i personaggi, con il mondo, con le relazioni, le sorprese e quant’altro in cui il libro mi ha condotta; dentro i pensieri e le filosofie di un libro-mondo. La storia non potrà essere che qualcosa di lieve, giusto un alibi. Ripeto quanto ho già scritto: “Il giovane Hans Carstop, in procinto di iniziare il suo primo lavoro come ingegnere navale, si reca nel Berghof di Davos, un sanatorio in alta montagna dove è ricoverato il cugino Joachim Ziemmsen, ammalato di tubercolosi, per una visita-vacanza di tre settimane.”
Ancora una volta, se pur diversamente, mi richiama il sostare, un momento, nel fermo-tempo?
Hans rimarrà sette anni a Davos. Vivendo tempi diversi, sempre uguali, nell’intreccio con altre vite. Difficile considerarlo il protagonista di questa storia, se non come punto privilegiato per lo sguardo dell’autore sulle vite che si svolgono, e si consumano, nella malattia, nel Berghof.
Joachim Ziemmsen il cugino, figura speculare di militare che sogna, brama, il ritorno a valle, al suo destino di ufficiale, al servizio della patria, in un mondo ordinato dove il pensiero, i pruriti esistenziali, le filosofie di vita, non hanno luogo e il dovere, e l’obbedienza, risolvono una vita onorevole e desiderabile.
Clavdia Chauchat, un amore che incatena il giovane Hans; no, una seduzione, che nasce da un richiamo dell’adolescenza, da un amore per un compagno di scuola, cui aveva chiesto in prestito una matita; l’uguale sguardo, ancora il prestito di una matita.
Ospiti, che spariscono, il riflettore illumina brani di vita, storie.
I medici del Berghof, figure ieratiche, deificate e contorte, malate; storie di vita sussurrate tra i pazienti.
Poi, protagonisti, motori della storia, Lodovico Settembrini, cui si aggiungerà Leo Naphta: il primo, deuteragonista positivo, l’italiano massone, laico illuminista, mentore del giovane Hans. Un improbabile Virgilio che vorrebbe guidarlo verso la guarigione e la vita, sulla strada della coscienza vigile.
Leo Naphta, l’ebreo gesuita mancato, negatore di ogni ragione, del valore della corporeità. Fautore della verità della malattia, intrinseca all’uomo, cosignificante della corporeità.
Ambedue, esterni al Berghof, catturati in un luogo-tempo tra terra e cielo: vincolati alla montagna dalla malattia; dentro la vita, al paese. Esterni all’”Incantesimo: Formula magica – ci dice il Vocabolario Treccani – spesso accompagnata da gesti rituali, con la quale si priva una persona della coscienza o della volontà”.
all’”Incantesimo: Formula magica – ci dice il Vocabolario Treccani – spesso accompagnata da gesti rituali, con la quale si priva una persona della coscienza o della volontà”.
In questi giorni, Davos torna nel telegiornale. Altro scenario. Chi c’è, chi manca. Davvero sarà possibile lasciare a valle un mondo malato; mentre improbabili dottori agiscono in alta quota stregonerie “scientifiche” di cura?
Incantesimo. Qualcosa cui non si sfugge, qualcosa che trattiene dentro un tempo circolare, dentro ritualità che non contemplano un prima e un poi diverso dal farsi, ogni giorno uguale, del giorno e della notte; nel ripetersi delle stagioni, in un lieve sfumare del biancore assoluto nel verde dei prati, breve, fragile; nello spuntare di fiori nuovi, diversi.
Incredibile quest’esperienza di lettura. Ho sempre saputo di un errore, profondo, del ricordo della mia antica lettura – e tocca dire <antica>, senza tema di eccesso nell’aggettivo. I troppi anni trascorsi da allora non avevano scalfito né il ricordo (storia, personaggi) né, pensavo, l’emozione – invece ora inconcepibile – che mi aveva regalato questo libro: un sentimento della bellezza, della pace di quel luogo; di sospensione, a suo modo positiva, del tempo; che si coniugava con un sentimento di morte che il tempo fermo permetteva di non attualizzare come propria; un altolà, da far valere fino a quando non vi si avesse consentito.
Qualcosa del genere. Immagino. Da un mio ora esterrefatto.
Fallaci, i ricordi, lo sappiamo bene, pur se dicono qualcosa di noi, di ciò che eravamo, di ciò che oggi siamo, anche attraverso l’errore che possono rappresentare, mai casuale.
È lecito un sospetto sulla fallacia di tale ricordo. Il ricordo erroneo, combinato a questa, di un’altra lettura? Mi ripeto: nel mio ricordo era stato una lettura <felice>, d’un fiato; non allegra, certo; ma ero giovane e, da giovani, non si amano i libri allegri; si reggono ottimamente le sofferenze, la malattia, la morte: che non ci riguardano; che si ricercano, addirittura.
Vale per i libri ciò che vale per i film: Bellissimo…ho pianto tutto il tempo!
La felicità: tesi nell’attesa della nostra, certa, che sta proprio là, manca poco! Da giovani, empatizziamo profondamente con l’infelicità altrui, con l’infelicità del mondo, da una visuale che comprende una certa quale alterità: di noi, della nostra vita. La nostra personale felicità è lì, sta davanti a noi. Immagino. Anche dentro l’infelicità più nera.
Per questo, quando l’infelicità ci coglie davvero siamo totalmente impreparati; ed è devastante, senza mediazione del tempo – da giovani.
E ora? Ci sono stata bene, anche, al Berghof di Davos. Preso a piccoli sorsi. Quasi una visita, diciamo settimanale, ad Hans; un paio di giorni di fermo-tempo, la chaise longue, al sole, nel freddo asciutto d’alta quota, avvolta nelle coperte – imparata la tecnica per impacchettarsi per bene, un libro; ma a ben vedere neanche quello, non veramente; assente anche il pensiero.
No, il pensiero no.
Le ultime quattro pagine. Le scorro. Rileggo.
Scelgo di non averlo fatto; di non chiudere.
“Via, via! Questo non lo vogliamo narrare!