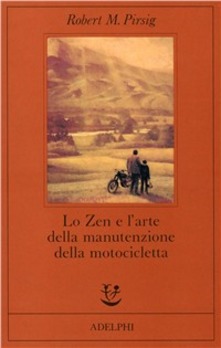Robert Maynard Pirsig, “Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta”, Prima pubblicazione italiana: Adelphi 1981
Robert Maynard Pirsig, “Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta”, Prima pubblicazione italiana: Adelphi 1981
Traduzione Delfina Vezzoli
“E ciò che è bene, Fedro,
e ciò che non è bene –
dobbiamo chiedere ad altri di dirci queste cose?”
Tema: il Viaggio, che il protagonista-autore compie In motocicletta, con il figlio undicenne attraverso l’America, dal Minnesota alla California.
Il viaggio come filo di Arianna della propria vita da recuperare; di un percorso di riavvicinamento al figlio che si era forzatamente interrotto; e per il recupero del rapporto con un suo precedente sé, scomparso – dalla memoria? Anche.
C’era stato, nella prima parte della vita dell’autore, giovane professore di retorica, spezzata in due da una crisi di schizofrenia, un percorso del pensiero che lo aveva condotto al di fuori di sé. Poi l’elettroshock, la cesura. La linea di faglia.
C’era ora il viaggio; con il figlio, Chris; e c’era con lui il suo doppio, Fedro[i], il retore, da far riemergere; un alter ego da ritrovare, che l’elettroshock aveva cancellato; ora solo un barlume di sé, titolare di un pensiero spezzato da cui ricominciare la ricostruzione di una identità; e un progetto di vita in cui concretarla.
Un libro di viaggio porta con sé immagini, mondi, panorami, dove il piccolo e il grande si fondono; porta con sé brevi incontri carichi di intensità; lampi di vite altre. E su ognuno di questi momenti accadono, improvvisi o inavvertiti, cambi di spessore, di colore e di qualità del tempo; incontri, che guardi passare, ne variano il ritmo e il sentimento; ad ogni variazione della strada, il pensiero accompagna i sensi che incamerano sintonie da percepire e distonie che la stanzialità del quotidiano oscura.
La prima parte del viaggio ha, quali compagni Sylvia e John, una coppie di amici.
Le due moto vanno, in sincrono, lasciandosi, distanziandosi, riprendendosi (come la loro relazione) mentre il protagonista segue un proprio progetto di Chautauqua – e oggi come allora, quando lessi per la prima volta questo libro, era il 1981 o giù di lì, non sono mai riuscita a dare un contenuto chiaro al termine, qualcosa come uno spettacolo ambulante in cui qualcuno svolge una lezione o un pensiero? E quest’indeterminatezza mantiene per me un grande fascino, come sempre accade quando dentro una parola ci puoi mettere tante cose, che decidi tu, ogni giorno nuove, anche solo per quel giorno, per un frammento di pensiero che poi fugge. Talvolta penso che sia per questo che il pensiero, la parola e il concetto, di Dio hanno e sempre avranno per la gran parte della gente una grande forza di penetrazione.
Una prima linea di pensiero, e di racconto del viaggio, si avvierà con il bisogno di svolgere piccoli regolari interventi di manutenzione della motocicletta, che il protagonista ritiene connaturati al viaggio, al suo essere un’esperienza di Qualità; che l’amico John respinge con fastidio, quasi un inquinamento dell’esperienza che la tecnologia, ogni tecnologia, porta con sé.
È l’America di quegli anni, scissa tra il sogno hippie, in cui ci si immergeva e ci si perdeva, e il mondo della tecnologia, quello che aveva già imboccato la via verso il nostro oggi – ma chi avrebbe potuto allora immaginare l’alterità degli anni che stiamo vivendo, anche se si tratta solo di un battito d’ali del tempo: sono trascorsi poco più di quarant’anni da allora.
La tecnologia caratterizzata da un vissuto di mediocrità, dall’assenza di qualità dei suoi prodotti, dall’assenza, percepita e voluta, di disponibilità nelle mani di chi la fruisce; la tecnologia che rende l’uomo <massa> in un mondo disumanizzato costituiranno il tema del viaggio, la ricerca di una Metafisica della Qualità come punto di recupero dell’unità tra materia e pensiero.
“L’altra sera dicevo a Chris che Fedro passò la vita ad inseguire un fantasma. …Il fantasma della razionalità stessa. E dicevo a Chris che alla fine Fedro lo trovò e lo bastonò di santa ragione.”
La spaccatura del pensiero, “tra quello che l’uomo fa e quello che l’uomo è”; la spaccatura tra “pensiero classico” e “pensiero romantico” – così li scinde il protagonista – sta nel problema del “tenere a quello che si fa”. E per superarla occorre recuperare una sintesi con Fedro: il pazzo.
“E quando guardi un pazzo senza mediazioni non vedi che il riflesso della tua consapevolezza che è pazzo, il che equivale a non vederlo affatto. Per vederlo devi guardare la realtà con i suoi occhi…altrimenti le tue opinioni ti sbarrano la strada”.
Il viaggio prosegue, percorrendo i luoghi dove Fedro, l’altro da lui, aveva vissuto, e aveva conosciuto il dramma della sua mente alla ricerca di un punto di unità tra il pensiero orientale e il pensiero occidentale; tra il Buddha e il Fedro di Platone e, dall’altra parte, il pensiero aristotelico; tra il pensiero scientifico e spezzato e un pensiero olistico dell’essere, un pensiero sui valori umani; sulla Qualità, che rappresenta il necessario punto di sintesi; sul bisogno fondamentale di star dentro le cose che si fanno, la Qualità essendo ciò senza cui non sappiamo vivere; che non tollera scissioni.
“Il Buddha, il Divino, dimora nel circuito di un calcolatore o negli ingranaggi del cambio di una moto con lo stesso agio che in cima a una montagna o nei petali di un fiore. Pensare altrimenti equivale a sminuire il Buddha – il che equivale a sminuire se stessi. Ed è di questo che voglio discutere nel mio Chautauqua”
E mentre la moto va, e il pensiero si dipana, e dietro di lui il figlio si tiene aggrappato, il paesaggio scorre.
“Non siamo ancora nel Dakota, ma a giudicare dalla vastità delle praterie non dovremmo essere lontani. Certi prati sono blu di fiori di lino, si muovono in lunghe onde come la superficie dell’oceano. Le fattorie in lontananza sono così piccole che riusciamo a distinguerle a stento. “
Ma sto arrampicando su di una mia traduzione, che forse si mescola al mio pensiero in via di farsi su queste pagine. Un pensiero sbalordito al ricordo- non ricordo di quella tale che – in un tempo che non c’è più, ove stava una che non (ri)conosco – ha consumato queste pagine: trovandovi risposte?
Se così è, oggi incontro una nuova, diversa traduzione, che forse semplifica un pensiero che, in questa rilettura, cerca, o vive, una difficile riduzione della complessità, su pagine che, forse, oggi mi pare, arzigogolano, in parte, con lo strumento filosofico; che in parte peccano di ingenuità, di una bella ingenuità che, se un tempo ha avuto, e non solo per me, il fascino di una scoperta, di quelle che accendono una luce nel buio (perché i libri, un libro, fa anche, e forse soprattutto, questo) oggi mi affascina come un amarcord che, anche, mi confonde, e mi chiama alla ricerca del mio personale Fedro.
Mi riconduce al sapere che è sempre stato me e con me, ma da qualche parte dev’essere avvenuta, anche per me, una cesura; da qualche parte qualcosa–qualcuno dev’essere stato dimenticato, o rimasto silente – al mio fianco? Al fianco di ognuno di noi? Alla ricerca di Fedro? Oggi: alla fine del viaggio.
La storia prosegue. La seconda parte del viaggio vedrà il protagonista e il figlio viaggiare soli; Sylvia e John hanno concluso la loro parte di viaggio. E la relazione tra padre e figlio sarà un centro di gravità esplosivo del pensiero, fino a raggiungere il suo punto di ricomposizione, quando anche Fedro sarà integrato nel discorso. Quando:
“Potrò avere una motocicletta quando sarò abbastanza grande?”
“Sì, se saprai occupartene”
“Che cosa bisogna fare?”
“Tante cose. Le hai viste”.
“Me le farai vedere tutte?”
“Certo”
“È difficile?”
“No, se le fai nel modo giusto. È farle nel modo giusto che è difficile”.
“Oh”
“…Papà?…”
“Pensi che saprò farle nel modo giusto?”
“Penso di sì – rispondo – non credo che avrai problemi”.

A dieci anni di distanza dalla prima pubblicazione, avvenuta nel ’74, l’autore ha aggiunto una Postfazione, molto importante: per la lettura del libro, per la messa a fuoco del suo posto nella cultura di quegli anni, riconoscendo al libro, come causa di un inatteso successo lungo oltre due generazioni di lettori (aveva avuto 112 respingimenti da editori) la qualità di uno di quei libri che, senza essere capolavori letterari (ma questo lo è), si rivelano, per la società in cui nascono, portatori di cultura, rivelatori di un cambiamento di paradigma in procinto di farsi.
È ancora un libro che chiede di essere letto; e riscritto da chi lo legge; capace ancora di portare cultura. Un nuovo paradigma.
La Postfazione ci dice anche ciò che il futuro ha portato nella vita del protagonista e del figlio Chris.
Pirsig non ha scritto altro per diciassette anni, fino alla pubblicazione del suo secondo e ultimo libro: “Lila”, Adelphi 1992. Un libro che non ho mai letto. Per scelta.
Ci sono autori di un libro solo e, per me, Pirsig, è stato questo.
Sono trascorsi, a giorni, due anni dalla morte di Robert Pirsig. La critica, e i lettori, non hanno decretato al suo secondo libro – ancora un viaggio, in barca – il successo del primo. Ora tuttavia si trova sul mio tavolo. Per me, ora, una chiusura, necessaria, del cerchio.
__________________________________
[i] Vedi, se interessa, Fedro, Platone, in: “Platone, tutti gli scritti”, a cura di Giovanni Reale. Rusconi 1991