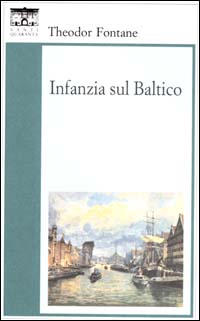Questa non è una recensione. Anche se c’è un libro, la cui lettura mi piacerebbe condividere; con il desiderio, tuttavia, di ricercare il particolare legame che un libro, e forse qualcuno più di altri (ma non è detto), intreccia con la vita del suo lettore; con una storia individuale, nel tempo e nei giorni in cui viene letto.
Questa non è una recensione. Anche se c’è un libro, la cui lettura mi piacerebbe condividere; con il desiderio, tuttavia, di ricercare il particolare legame che un libro, e forse qualcuno più di altri (ma non è detto), intreccia con la vita del suo lettore; con una storia individuale, nel tempo e nei giorni in cui viene letto.
Quando vita e lettura si intrecciano, il libro colora le esperienze, che a loro volta segneranno le pagine con le luci e le ombre del nostro personale tempo.
Avviene che i ricordi portino a mutare la sostanza della pagina letta, venendone a loro volta mutati. Capita, di scoprirsi incerti tra l’aver vissuto un qualcosa in prima persona e l’averne letto, dentro una singolare mescolanza di esperienze. Trasformati dal nostro particolare, i libri faranno di noi la persona che siamo, sempre provvisoriamente. Le pagine lette intruderanno gli eventi della nostra vita, modificandone la forma.
La lettura evoca; la lettura modifica i nostri ricordi; la lettura li crea. Ad ognuno i suoi, del momento, che orienteranno letture successive di ciò che accadrà e ci accadrà; per suggestioni irripetibili, diversamente evocative.
In questi giorni sto leggendo a balzelloni, un po’ questo un po’ quello. Sono giorni particolari: sono in viaggio; troppo spesso, e per alcuni giorni di seguito, orfana di Wi-Fi (con annessa ira funesta). Sto leggendo “Infanzia sul Baltico”, di Theodor Fontane – lentamente, mantenendo una rarefatta continuità, matita alla mano, in momenti selezionati, come il libro richiede (e come richiedono giorni mobili e tranquillamente indaffarati). Non finirò questo libro velocemente. Non desidero farlo.
In “Infanzia sul Baltico” Theodor Fontane sta ripercorrendo la propria infanzia, a Swinemünde; la vita del tempo, un humus culturale che regolava “miti e riti” della famiglia e della comunità; i luoghi della formazione – la scuola, i giochi, le relazione della e nella famiglia.
Spicca, nel racconto, il ritratto del padre: un simpatico irresponsabile, giocatore, che dilapida, tra sensi di colpa e autoassoluzioni, le sostanze familiari.
Leggo, confronto, reagisco. È forse apparente l’affettuosa e sorridente comprensione da parte del figlio? Al di sotto della calda tollerante narrazione che ne compie l’autore giunge l’eco di una vendetta? Per un’infanzia sottilmente e tacitamente sofferta di cui ricostruire, per addomesticarne il ricordo, una versione buona? Oppure: quanto di questa lettura, che è pur sempre la mia, costituisce una qualche forma di identificazione? Per dettagli, emozioni, ricordi. E, alla fine, qual è il ricordo vero? Di Theodor Fontane, naturalmente. Ma non solo.
Fatta salva la verità per cui non esistono buone infanzie – il processo della crescita stira ossa e nervi di ognuno – una sottile ironia, facilmente e forse falsamente assimilabile al sorriso bonario, pervade la narrazione. È difficile districare lo sguardo dell’adulto sui conflitti, sui momenti di crisi tra i genitori causati dai comportamenti del padre e dai problemi che ne derivavano, dal vissuto del bambino; e non dover fare i conti con i propri ricordi infantili (il diverso tempo, i luoghi altri: le vite, le relazioni, sempre riconoscibili), non permearli dei propri ricordi, non derivarne una possibile variante – ci sono tanti modi di lettura della stessa cosa (o si tratta di un’altra?), tanti modi degli intrecci odio-amore-rancore-affetto-volontà di guardare negli occhi la propria vita-respingimento-ricerca di guardare attraverso uno sguardo altro.
Ma ci sono pure, determinanti nel dar colore a ciò che avviene, un contesto, un ambiente fisico, un ambiente sociale. Una comunità, con le sue classi sociali, i suoi notabili e non, le difficoltà economiche da combinare con gli obblighi di appartenenza. Le “Famiglie”. Le piccole grandi discendenze.

Si ascolta una narrazione, come ci si trovasse, la sera, comodamente seduti in compagnia, nel salotto di una vecchia casa di campagna. Un dopocena trascorso tra buoni conoscenti, con cui si condivida una frequentazione sociale declinata nella forma dell’amicizia, scandita dal ritrovarsi, a casa dell’uno o dell’altro, a cadenze fisse: buoni riti borghesi nel corso dei quali si creano quei conversari in cui, a turno, l’uno o l’altro dei partecipanti assume il ruolo del narratore. Si ricorda. Si ripercorrono fatti, storie di vita, conoscenze comuni, intere genealogie. A mezzo tra il ricordo condiviso e il pettegolezzo, acidulo, senza parere: salve, anzi benevole, le forme.
Ci si rassicura su di sé, sulla propria famiglia, sulla propria storia, nella condivisione: di un’infanzia, di un luogo, di un passato; mentre il tempo, elastico, si espande, si raccorcia, trascorre dall’ieri ad un presente che di quel ieri è figlio, di cui portiamo un incongruo personale ricordo, come di un già vissuto.
Ci troviamo nella prima metà dell’’800 – e per chi legge quel tempo diventa, se non il proprio, un tempo noto, potremmo dire consueto.
E il linguaggio? Come mi sono espressa, senza riflettervi? Ho scritto di “conversari”, e quando mai questo termine verrebbe usato oggi; ma in effetti, quelle che il libro evoca non sono “conversazioni” – che appartengono ad un nuovo tempo, che hanno un significato forse affine ma non veramente. Le forme della lingua cambiano, nel tempo; cambiano i significati, e la parola che si modifica, per variazioni anche minime, segnala l’abitare un mondo diverso.
Lo spazio, i luoghi, di cui si narra in queste pagine, oltre al tempo, non ci appartengono: nel mentre, ognuno a proprio modo, li riconosceremo. Come ricordi.
Leggo e assorbo tranquillità, storia di un vissuto elaborato e accolto; mentre ascolto, e posso sorriderne, una storia di vita a tutti gli effetti orribile; in un ambiente culturalmente anestetizzato. Leggo e assorbo l’annientamento, senza contraddittorio possibile (ogni accusa è ostentatamente assente) della figura paterna. A parricidio compiuto, dopotutto, ci può stare la riconciliazione.
Strumento potente, la cultura; i cui aspetti obsoleti, di necessità, possono venir recuperati e utilizzati, fuor di tempo e fuor di luogo: per comprendere, forse; sicuramente per accogliere.
Sarà così? Un libro – ogni libro, questo libro – pare possegga la capacità di frugare dentro alla nostra memoria, e in qualche modo pescarvi, riordinandoli, frammenti di un tempo altrui di cui – una memoria genealogica? – conserviamo tracce; che conserva, come nostri, fatti, luoghi e ambienti che ci sono stati narrati. Abbiamo tutti avuto dei nonni, dei bisnonni (almeno i più fortunati tra di noi); abbiamo variamente conosciuto, frequentato persone di altre età – la vita è per definizione un’esperienza intergenerazionale; è, per l’appunto, trasmissione culturale – che, a loro volta, conservavano una memoria più antica; e raccontavano, non solo con la parola: raccontavano con abitudini di vita, con gesti, con regole, scadute ma non scordate. Narravano, con parabole,, il come di una vita buona e sui modi giusti dell’intrattenere relazioni.
Seduti in quel salotto, mentre uno racconta della propria famiglia, racconta fatti del luogo, cose avvenute da non dimenticare – ci ritroviamo ad assentire. E riconosciamo un linguaggio.
Nel mentre, per poterlo fare bene, eccoci a – mi scapperebbe il dire: eccoci a compulsare un libro di storia, l’enciclopedia, quel tal romanzo. E invece no. Eccoci a smanettare in rete, alla ricerca di notizie su di un certo Re, sulla tale legge del tempo, su di un’antica battaglia, sulle norme che regolavano i commerci, su famiglie notabili – e com’era quella antica storia degli ugonotti, in fuga dalla Francia – e c’è la nuova moderna maledizione, la rete non funziona, e un senso di furia commista a irrealtà ci assale.
È una vertigine: sto vivendo là, in quel tempo, e certo, devo raggiungere un’informazione, trovare una cartina dei luoghi, altrimenti tutto va a patrasso; e nel mentre, dentro un preciso sentimento di appartenenza, di un reale abitare, in assonanza con un tempo e un luogo totalmente altri, mi sorprendo a non saper cosa fare di me – dentro quel tempo là, un tempo senza Wi-Fi!.
Mi ritrovo a raccontare a mio marito vecchie storie di famiglie, di vecchi conoscenti, dei miei genitori, addirittura dei miei nonni – appartengo alla storia delle persone fortunate, avendo avuto un’infanzia arricchita da sei bisnonni, e la trisavola se ne era da poco andata rimanendo presente, per vicinanza di vita, nei racconti di casa; e quattro nonni hanno conosciuto i miei figli e così i racconti sono seguiti ai racconti – sai, era una della famiglia Tal dei Tali, ma poi le cose non sono andate del tutto bene, la vecchia casa è stata venduta. Oggi c’è ancora ma tutto è cambiato – Il vecchio era un tipo strano; nessuno parlava, per il buon nome della famiglia, pure se tutti in paese sapevano. Un originale, ma chi non lo è?

Per la sera – a letto il cartaceo è meno funzionale, diciamolo. Il cuscino non consente matita, interruzioni per decriptare note, ricercare vocaboli desueti; per annotazioni a margine e quant’altro. E dunque, i gialli ormai antichi, siamo ora agli anni ’30 del ‘900, di Augusto De Angelis, le storie del Commissario De Vincenzi assolvono la bisogna: visto cosa succede? Anche qui; ancora pagine che marchiano il linguaggio con il loro tempo: chi mai oggi direbbe “assolvere la bisogna?” Che poi è termine decisamente più antico, controllo i vocabolari e la Crusca, ed ecco, Dante, Boccaccio; ma è anche, vedi un po’, parola sopravvissuta nel linguaggio burocratico. De Angelis? Epoca fascista? Burocrazia? Ci sta. Ci sta tutto. Ci sta ancora.
La sto facendo troppo lunga. Proseguirò domani. Nel frattempo, penso alla mia lettura delle pagine di Fontane. Avrà poco a che fare con il libro? Posso consigliarne la lettura? Certo sì. Ognuno a modo suo.