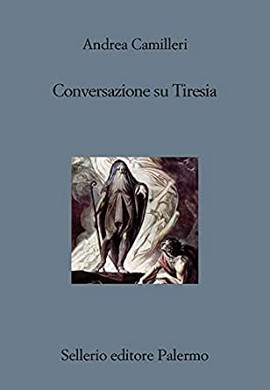Andrea Camilleri, “Conversazioni su Tiresia”, Sellerio 2019
Andrea Camilleri, “Autodifesa di Caino”, Sellerio 2019
“Conversazione su Tiresia”, scritto e interpretato da Andrea Camilleri, è andato in scena per la prima volta al Teatro Greco di Siracusa nel giugno 2018 nell’ambito del 54° Festival del Teatro Greco. Per la regia di Roberto Andò.
Nel giugno del 2019, mentre stava preparando “Autodifesa di Caino”, che sarebbe dovuto essere presentato il 15 luglio, a Roma, alle Terme di Caracalla, Andrea Camilleri è stato ricoverato d’urgenza.
La sera della sua morte, il 17 luglio 2019, la RAI gli ha reso omaggio con la messa in onda di “Conversazioni su Tiresia”.
Queste due rappresentazioni, che la morte dell’autore ha contrassegnato con la separazione, hanno rappresentato il messaggio con cui egli ha scelto di rimanere con noi – con cui ha segnato un suo personale consegnarsi, magari non all’eternità (era un uomo intelligente) ma almeno ad un perdurare del suo tempo, attraverso un lascito tematico della sua presenza e della sua parola.
Non avevo mai proposto pagine di Andrea Camilleri che pure, da me come, posso dire, da ognuno di noi, è stato sicuramente un autore letto, e apprezzato.
Non so dire il perché: forse proprio per il suo essere in relazione a tutti noi, vorrei dire indipendentemente dalla frequenza delle sue pagine lette: come presenza, come fisicità, nella storia-cronaca del nostro mondo italico.
Camilleri è stato scrittore – soprattutto in età anziana, quando aveva cessato le altre, forse più importanti, forme della sua presenza nel mondo della comunicazione e dei media – ma è stato soprattutto un importante facilitatore, dietro le quinte, di bellezza e intelligenza nel mondo del teatro, del cinema, della buona televisione.
È stato, in questi suoi ruoli, non ultimo nel ruolo didattico al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e all’Accademia nazionale di Arte drammatica, una presenza significativa e, per i non addetti ai lavori, nascosta lungo tutta la nostra storia, dal dopoguerra ad oggi – volendo considerare l’ambito della comunicazione e la vita dei media preminenti nel farsi di una cultura democratica nel nostro paese.
Un <attore>, dunque, nel senso proprio di <persona che agisce>, che <opera per>…fuori proscenio; l’artista-artefice cui, in un dietro il sipario, si deve la qualità del messaggio in cui il medium si trasforma.
Camilleri ha anche scritto, negli anni della sua maturità: senza successo. Vorrei dire senza chiederlo, senza proporsi. E tuttavia, come avrebbe potuto non ritagliare un piccolo spazio residuo alla sua natura di cantastorie.
Deve essere stato uno spazio frustrante per uno che ha saputo – dovuto? voluto? – trattenersi e continuare ad operare, ad essere autore ed attore, là dove maggiore era l’utilità della sua opera. Il premio della visibilità è stato, credo, è dovuto essere, in quegli anni, decisamente secondario.
Poi, il tempo è venuto. Con “l’età del pensionamento”? L’età in cui ci si ritrova a dire che il tempo potrà, finalmente, essere dedicato (anche) a se stessi?
Così dev’essere stato per un cantastorie impedito, che aveva dato quanto doveva e poteva alla propria comunità di appartenenza (compresa una militanza politica, dal senso alto, dentro un mondo importante e difficile).
Dagli anni ’90, e dal connubio con Sellerio è, neppure troppo lentamente, scoppiato il fenomeno Camilleri. È emerso lo scrittore di sicuro mestiere, nel cui ruolo egli ha potuto, finalmente, raccontare storie, recitare, fare educatamente ma per niente sommessamente, una sua azione “politica”: da vecchio signore siciliano (si fa per dire: di uno la cui vita, dai trent’anni in poi, si è svolta a Roma; uno cui un indiscutibile amore per la sicilianità ha chiesto l’invenzione di una lingua ad hoc, oltre che del Comune di Vigata).
Fino ai saluti finali: cieco, sulla scena. Per chiudere la propria vita là, dove, da regista teatrale aveva contribuito a dare voce alla storia del teatro italiano.
La cecità non l’ha fermato: e ha prodotto, nel finale, il gioco a rappresentare-rappresentarsi come l’indovino Tiresia, nelle multiformità che il personaggio ha assunto nei secoli (va bene: millenni). Dicendo – cosa non consueta, per lui, e finalmente: “Sono io; in persona; personalmente”.
Il pubblico ha risposto. E questi suoi due ultimi testi meritano una lettura. Gli è dovuta.
La rappresentazione di “Conversazioni su Tiresia” fu un successo – un saluto, dato e ricambiato.
Tiresia si presenta – di persona:
“Chiamatemi Tiresia…. Oppure Tiresia sono”
“Qualcuno di voi certo avrà visto il mio personaggio su questo stesso palco negli anni passati, ma si trattava di attori che mi interpretavano.
Oggi sono venuto di persona perché…”
Tiresia narra la propria storia, narra la storia di chiunque abbia avuto una lunga vita e si sia trovato a dover vivere, nella relazione ad altri, molte vite e molte identità.
“Zeus mi diede la possibilità di vivere sette esistenze e questa è una delle sette. Non posso dirvi quale.”
Narra il suo esser divenuto donna per aver ucciso una serpe femmina impegnata nell’atto della riproduzione; per aver spezzato l’unità di due.
“…ricevere un cervello di donna.
E questo mi atterrì.
Meglio non conoscere a fondo i pensieri che possono agitare la mente di una donna. Un cervello affollatissimo (…) un flusso continuo di cose da fare e altre da pensare. Tutto questo sempre in contemporanea, senza requie, senza riposo. Un inferno!”
Narra, Tiresia, il <dono> della cecità, che Era gli inflisse; narra le tante storie che su di lui e sul suo destino furono raccontate. Narra la scomparsa degli dei, con cui, pensava, sarebbe dovuto scomparire anche lui e invece no. Narra come di lui, del suo personaggio, si siano impadroniti in tanti, per esaltare o demolire la sua figura, attraverso i secoli, fino a giungere a Primo Levi che, in La chiave a stella, gli dedicò un racconto: sui campi di concentramento; dove Levi “rischiò una metamorfosi peggiore della mia, quella da uomo a non uomo, e che a salvarlo fu proprio la poesia.“
E chiude:
“Devo confessarvi che mai io previdi quell’orrore. È stato un orrore al di fuori anche dell’immaginazione allenata da tante vite e aperta ad ogni rischio.”
“Ho finito”
Andrea Camilleri si commiata.
“Può darsi che ci rivediamo tra cent’anni in questo stesso posto. Me lo auguro. Ve lo auguro.”
È stato il commiato, in effetti. Ma Andrea Camilleri non ha rinunciato; dopo aver scritto e curato la regia di cento opere teatrali, e fatto molte altre cose; dopo aver scritto più di cento libri; dopo aver creato e sperimentato, eccolo ancora al lavoro.
Eccolo ancora a congedarsi – hai visto mai. E poi, le storie, anche quelle di un cantastorie, nate per essere parlate, possono essere scritte; e da lì, parlate ancora, e ascoltate, anche nel silenzio della lettura solitaria guardando con gli occhi della mente a chi narra, e ai tanti, alla moltitudine che ascolta.
Il Nostro, dopo questo saluto, non ha rinunciato, dicevo, a dar vita alla sua vita. Ha scelto di venir fermato in cammino.
Ed ecco Caino: la sua autodifesa. Importante per tutti noi che, non scordiamolo, siamo i suoi figli. Non indegni.
Racconta, Caino; rivisita per noi la Genesi dopo aver constatato come, da parte del pubblico, il suo nome, la sua persona non abbiano suscitato repulsa alcuna.
Caino attendeva, come di regola, di venir maledetto, e – ma solo inizialmente, per un breve momento – lo stupisce una platea di gente composta, pronta ad ascoltare; non pregiudizialmente mal disposta nei suoi confronti.
Si presenta: è il primo assassino della storia umana; e…
“…voi ve ne state tranquilli al vostro posto…
(sullo schermo appaiono immagini di soldati e civili che giacciono a terra senza vita)…”
“In effetti, solo negli ultimi centocinquant’anni, ne avete visti di morti…. E (…) c’è ancora chi ha il coraggio di dire che è stata tutta colpa mia? Che se non ci fossi stato io, avreste amato il vostro prossimo come voi stessi? Ma va…va’…”
Caino narra: dal principio, naturalmente. Da quando, dopo aver completato la creazione in sei giorni Dio si riposò – prima di aver dato vita all’uomo: che venne dopo.. A rallegrare il giardino, diciamo.
E vai e vai. L’affabulazione (e gli agganci alla cronaca, al tempo che condivide con il suo pubblico) prosegue.
Il commiato dirà, ricorderà, la determinazione di Dio a punirlo; ma pure a salvarlo:
“Nessuno tocchi Caino”.
Nella durezza della pena; nelle tante storie e storielle sulla sua figura, Caino, ricorda le cose buone che ha inventato. Ultima, ma prima, la musica.
Ricorda come Dio – in risposta alla sua autodifesa: aver ucciso Abele perché quest’ultimo voleva uccidere lui – gli ha parlato dell’importanza, nella vita, della <scelta>: vero, Abele voleva uccidere suo fratello, ma ha scelto di non farlo; Caino ha scelto di farlo. Ecco tutto.
Caino-Camilleri chiude l’argomento con una riflessione:
“Devo confessarvi che non sempre dal bene nasce altro bene e che non sempre il male genera altro male.”
Per me: ora ascolterò il telegiornale. Guerra in Europa? Ma come!
C’era da tempo; noi, facevamo finta; abbiamo scelto di non vedere. Scegliendo un modo accettabile della guerra? “Ma va…va“
Non ho voglia di ascoltare il telegiornale ma non farlo non esorcizza nulla.